
Stefano Santomaso, il funambolo agordino fra Moiazza e Pale di San Lucano
di Pierangelo Verri
Mi piace pensare che ancora ai giorni nostri, l’apertura di una via su
di una parete in montagna, sia la continuazione storica di
quell’alpinismo eroico ed esplorativo dei primi del 1900 che aveva come
scopo il raggiungimento delle cime ancora non salite. Le sensazioni che
si provano sono le medesime: su di un percorso di centinaia di metri
verticali, dove nessuno ha mai messo la mano e dove ogni passo è un
azzardo verso l’ignoto, ci sentiamo in un certo modo degli avventurieri.
L’arrampicata in quelle situazioni diventa speciale e ti costringe a
vivere il presente, finché non arrivi in cima tutto il resto conta poco,
poi quando scendi sei già proiettato al futuro e non riesci a godere,
come in quei momenti d’azione quel che stai facendo.
Fa sorridere nell’epoca dell’arrampicata sportiva e del 9c, ma per chi
come me l’ha provata questa esperienza, il piacere di essere i primi a
disegnare una linea invisibile su una parete in montagna, al di là della
difficoltà, diventa una sorta di vanto con sé stessi che conduce
l’attività arrampicatoria quasi esclusivamente in quel senso.
Si rischia, come nel mio caso, di diventare dipendenti da quell’euforia
e forse un po’ egoisti, tanto da voler dipingere tutte le pareti con la
propria mano. Va detto comunque che, da questa smania di tanti pittori
che hanno realizzato opere un po’ su tutte le montagne, si sono
realizzati dei veri capolavori di itinerari alpinistici ripetuti da
centinaia di appassionati, mettendo le basi per la crescita
dell’alpinismo tutt’ora in evoluzione.
Crescita che si è realizzata su tutti i gruppi alpini e che in ogni
luogo ha avuto per ogni periodo i suoi più attivi esploratori ed
apritori, come nel caso del circondario Agordino che negli ultimi
trent’anni ha portato la firma da protagonista di Stefano Santomaso.
Stefano l’ho conosciuto di persona solo l’anno scorso nella Valle di
Schievenin dove ci siamo divertiti facendo due tiri in compagnia, e
discutendo subito con affinità di vie nuove e dei Monti del Sole,
montagne che entrambi amiamo. La prima impressione che ho di lui come
alpinista, è di un arrampicatore sicuro di sé, che sa muoversi con
equilibrio senza azzardare mai, che sa manovrare con la corda e gli
attrezzi con disinvoltura ed esperienza. Mi appenderei con lui anche ad
occhi chiusi. Lo rincontro poi recentemente, per tentare timidamente di
conoscerlo meglio e presentarlo ai nuovi proseliti della montagna. Penso
che la sua enorme esperienza vada tenuta viva per arricchire la nostra
conoscenza e comunque per farci sognare ancora …

Stefano Santomaso è nato ad Agordo nel 1971, ed ha vissuto fino a prima
di sposarsi a Farenzena, una piccola località posta sulle pendici del
Framònt sopra Agordo. Il suo sguardo si è posato fin dall’infanzia su un
corollario da fiaba, formato dalle maestose pareti delle Pale di San
Lucano e dagli infiniti e vertiginosi spigoli dell’Agner, per poi
spaziare più a sud e perdersi sui contorti fianchi dei Monti del Sole e
delle Alpi Feltrine.
I primi passi sulle cime circostanti, fin da piccolo, con i genitori,
nei momenti in cui la famiglia che seguiva i ritmi di una vita
contadina, trovavano un momento di relax.
Ora vive ad Agordo, con la moglie Mara e tre figli: Manuel di diciotto
anni, Martina di quindici e Silvia di dodici, una famiglia bella e
solare, con un animo forte e sincero come da tradizione montanara.
Completa il bel quadretto la mole simpatica di un bovaro del bernese di
nome Lares, un cane affettuoso che Stefano considera come un quarto
figlio.
La prima domanda che ti voglio fare, può apparire scontata e banale
ma secondo me è fondamentale per far capire fino in fondo quale percorso
hai intrapreso e da dove è nata una storia ricca di avventura come la
tua. Cosa ti ha spinto verso il mondo verticale e quando e dove hai
iniziato ad arrampicare?
La mia prima arrampicata è avvenuta sul terrazzo di casa, al terzo
piano, quando avevo circa un anno e mezzo: mi sono arrampicato sul
parapetto scavalcandolo e cadendo di sotto… Illeso!
 Un metro e mezzo di scalata e un volo di circa otto metri…
Un inizio promettente?
Un metro e mezzo di scalata e un volo di circa otto metri…
Un inizio promettente?
Ho iniziato ad arrampicare sulla roccia da autodidatta giovanissimo,
credo intorno ai dodici anni: a poche centinaia di metri da casa mia
c’era la storica palestra di roccia di Agordo dei “Crodoloi” (grandi
massi) così, tante volte per ammazzare il tempo (non c’erano poi tanti
altri diversivi), ci andavo da solo e provavo a salire in cima a quei
massi più o meno alti.
Naturalmente di nascosto e in segreto perché la preoccupazione dei miei
genitori era tanta: non erano passati così tanti anni dalle tragedie
delle fatali cadute dei rocciatori Agordini: Gianni Costantini, Renzo
Conedera e Gigi Decima, e l’alpinismo era considerato un’attività molto
pericolosa, assolutamente da non fare!
Naturalmente quando veniva qualcuno ad allenarsi (al tempo non c’erano
gli spit) io ero lì ad osservare, finché qualcuno si è impietosito e mi
ha detto “vuoi provare?”. Da quel momento non ho più smesso!
Mi riconosco un po’ nel tuo percorso, solo che io ho avuto la
sfortuna d’iniziare a ventidue anni, sono maturato poi leggendo le
storie dei grandi alpinisti del passato. Nel tuo caso ci sono stati dei
maestri o degli alpinisti di riferimento che ti hanno guidato nella tua
crescita alpinistica?
Ho avuto la grande fortuna di legarmi assieme alla generazione di
alpinisti agordini che mi precedeva, tutti alpinisti molto forti un po’
più vecchi di me e da cui ho imparato molto; per tanti tanti anni ero
considerato “el bocia” ed ero il più giovane della compagnia.
Lorenzo Massarotto era un liberista puro, da lui ho imparato a
proteggermi con poco e il rispetto per la roccia, da Giorgio Anghileri
la classe e determinazione, ma ero particolarmente affascinato dalle
linee aperte dai trentini Graziano Maffei, Mariano Frizzera e Paolo
Leoni che trovavo di una logica straordinaria. Anche Bruno De Donà
concreto e silenzioso era un mito.
Hai iniziato anche tu nel momento in cui l’arrampicata sportiva stava
gettando le sue fondamenta, com’è stato il tuo approccio con le prime
salite a più tiri e poi con l’alpinismo vero e proprio?
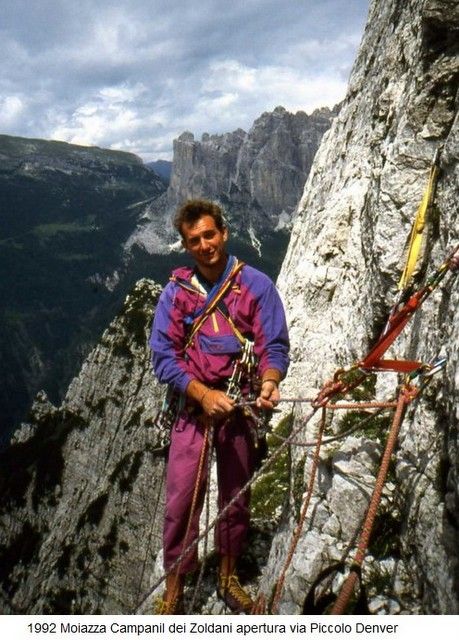 Gli anni Ottanta erano un periodo di cambiamento radicale e molto
florido per l’arrampicata e l’alpinismo dolomitico; ma non si aveva una
gran consapevolezza sul reale impegno delle vie.
Gli anni Ottanta erano un periodo di cambiamento radicale e molto
florido per l’arrampicata e l’alpinismo dolomitico; ma non si aveva una
gran consapevolezza sul reale impegno delle vie.
Così la mia prima via a più tiri, a sedici anni, è stato anche il mio
battesimo del fuoco; ho ancora un ricordo lucido di quella salita, la
via “Satanasso” sulla Parete dei Falchi a Soverzene (una via di Manolo e
Gigi Dal Pozzo): il terrore che ho avuto nel salire quella via così alta
e strapiombante progredendo come meglio potevo su chiodi legati con il
fil di ferro. Anche Lucertola Schizofrenica in Totoga, ha avuto il suo
gran tributo di sudore per riuscir a guadagnare il boschetto sommitale!
Oggi ci sono gli spit su quelle vie, ma un tempo nemmeno li vedevi i
chiodi da distanti che erano!
Il salto poi al vero alpinismo e alle grandi pareti dell’Agner, Civetta
e Pale di San Lucano è stato rapido ed immediato: a vent’anni avevo già
ripetuto in giornata tutte le vie di Casarotto sulle Pale di San Lucano,
le vie di Aste sugli Spiz d’Agner, alcune di Maffei in Vallaccia, tante
vie di Massarotto e anche molte vie nuove…
Appena potevamo arrampicavamo sempre, muovendoci in perfetta simbiosi
con le montagne che salivamo: i tempi di salita erano indicativi dello
stato di grazia in cui ci trovavamo: cinque ore per la Cassin sulla
Torre Trieste, sei ore e mezza per la Casarotto alla Sud della Quarta
Pala di San Lucano, cinque ore per il Casarotto - De Donà allo Spiz di
Lagunaz. Tieni conto che noi non facevamo le gare ed erano prime
ripetizioni di itinerari ancora selvaggi e per niente chiodati, credo
siano ancor oggi buone tempistiche.
I numeri non sono importanti… Sono tanti anni che non tengo più un
diario delle salite, circa una decina di anni fa ne avevo contate più di
seicento… a oggi credo che saranno più o meno un migliaio, di cui tante
prime ripetizioni.
Impressionante! Sono tempi importanti, praticabili anche oggi, solo
da chi va veramente.
Immagino che con una marcia in più come quella, tu abbia fatto anche
delle solitarie?
Le solitarie? Sono roba da duri… io sono un fifone!
A dir la verità ogni tanto arrampico solo e senza corda, anche su
qualche via nuova mi è capitato, ma è sempre stata una condizione
derivata dall’emergenza di non avere il compagno più che una
pianificazione vera e propria.
In ogni caso su itinerari dove so di dominare bene il grado.
E dell’alpinismo invernale, cosa ne pensi, mi risulta che l’hai
praticato, ma so poco di te in questo senso, mi vuoi raccontare
qualcosa?
Se intendi invernali come usualmente si considerano tutte le salite
fatta nella stagione invernale direi che ne ho fatte parecchie, intendo
quelle con un bel sole e poca neve!
Ma se parliamo delle invernali quelle vere, su pareti ombrose scalate
con perennemente i geloni alle dita e gli scarponi ai piedi e zaini
giganteschi, la mia attività si riduce notevolmente.
Ogni tanto quando ho voglia di soffrire un po’ e “autopunirmi” ci vado
ad arrampicare a nord in inverno.
In quello scorso per esempio con Toni Zuech ho ripetuto la Via Gogna
sulla parete ovest del Campanil dei Zoldani e la via Angelina alle Torri
del Camp. Direi che due vie all’anno sono una punizione più che
sufficiente!
Capisco … lo sapevo che il tuo alpinismo ha come attività peculiare
l’apertura di vie, affascina anche me, ne avrai aperte moltissime, cos’è
che ti spinge in quel senso?
 Ho fatto tantissime vie nuove, a oggi sono circa centotrenta ed ho
iniziato da subito. Aprire è la mia specialità. Nelle vie nuove cerco
sempre l’avventura più totale che a volte si manifesta dallo stile di
scalata, altre volte attraverso la parete o l’isolamento della montagna.
Una via nuova è la perfetta rappresentazione sulla roccia del nostro
essere uomo. Quando apriamo una via sulla parete non è che scaliamo
solo, ma ci trasportiamo parti di noi stessi: l’umiltà, la creatività,
l’intuito, il coraggio, la determinazione ecc..
Ho fatto tantissime vie nuove, a oggi sono circa centotrenta ed ho
iniziato da subito. Aprire è la mia specialità. Nelle vie nuove cerco
sempre l’avventura più totale che a volte si manifesta dallo stile di
scalata, altre volte attraverso la parete o l’isolamento della montagna.
Una via nuova è la perfetta rappresentazione sulla roccia del nostro
essere uomo. Quando apriamo una via sulla parete non è che scaliamo
solo, ma ci trasportiamo parti di noi stessi: l’umiltà, la creatività,
l’intuito, il coraggio, la determinazione ecc..
O anche cose negative come magari agitazione, aggressività o arroganza
in tanti casi. Le vie nuove sono l’espressione di chi le ha create e
anche talvolta lo specchio della società in cui viviamo.
Anche la scelta delle pareti secondo me non è del tutto casuale; esiste
sempre un fattore psicologico più o meno occulto. All’opposto, quando
ripeti una via se sai cogliere le caratteristiche dell’arrampicata è
come se andassi a conoscere l’apritore. Aprire una via è un’arte, come
lasciare una traccia di noi nella montagna e nell’immensità del tempo.
Non si può non esserne attratti!
So che le tue vie sono state aperte quasi tutte in modo tradizionale,
con il classico chiodo per intenderci, e questo rende le tue opere
ancora più impegnative da realizzare, ne hai qualcuna che ricordi in
particolare per il grande impegno alpinistico?
Aprire una via con protezioni removibili, include sempre la
possibilità di non riuscire a passare, c’è magari la paura di non
riuscire a fare una buona sosta alla fine del tiro o c’è la
consapevolezza di avere grandi difficoltà in un eventuale ritorno
forzato. In quest’ottica ho ricordi importanti di vie impegnative aperte
nei primi anni novanta con Gianni Del Din sulle pareti nord degli Spiz
d’Agner Nord, sulla solitaria parete del Pizzon nei Monti del Sole si è
incredibilmente soli, anche la friabile parete della Moiazza Sud è
pericolosa e alpinisticamente impegnativa.
“Ogni pane ha la sua crosta”, infatti in questi luoghi non ci va
nessuno!
Ci sono comunque tante vie che hai aperto, che sono belle e su roccia
compatta, qualcuna viaggia anche su difficoltà tecniche elevate, quali
sono quelle a cui sei più legato o che comunque consiglieresti a tutti?
È una domanda difficile! Le vie sono come le donne, a non tutti piace
la stessa! Sennò il mondo mica andrebbe avanti. Non ho mai ricercato
l’impegno tecnico in un nuovo itinerario; la difficoltà pura intesa come
il raggiungimento del proprio limite che un po’ tutti ricercano al
giorno d’oggi in parete, è solo un valore astratto a cui decidiamo di
dare molta importanza. È l’aspetto matematico e razionale della scalata.
Io che sono un “romantico” preferisco guardare di più l’estetica della
via; come la via si sviluppa sulla parete e si inserisce nella montagna.
Naturalmente lo stile di apertura è fondamentale.
Forse la via che più mi rappresenta l’ho aperta sulla parete est della
Quarta Pala di San Lucano “via Mario Tomè Barìza”, è una linea ideale su
una parete selvaggia bellissima. Fare una salita accanto ad una via di
Gogna e a una di Casarotto; cosa si può chiedere di più? È
un’arrampicata fantastica ma non è proprio una via per tutti!
Considerando gli standard attuali mi pare che la gente si diverta di più
su pareti meno smisurate e su vie più chiodate, la Moiazza è ideale: a
tutti proporrei vie come “Bracco Dream” sulla Torre del Camp, “Ritorno
al Far West” sul Torrione dei Cantòi o per gli amanti delle vie ariose
“Fantasma Giallo” dove recentemente Heinz Grill ha aggiunto alcuni
chiodi per favorirne la ripetizione. Anche sulle pareti sud dell’Agner
ho aperto molte vie meritevoli; consiglio lo spigolo sud della Punta del
Nevaio, molto bello! Oppure per gli alpinisti più classici lo spigolo
Est dello Spiz della Lastia, il Pizzetto Est… Potrei continuare a lungo
con altre vie, altre pareti…
Non ne dubito ce ne sarebbero da riempire un libro, ne hai fatte
davvero tantissime, a questo proposito quello che mi preoccupa, è che
per le nuove generazioni resti poco o niente da fare, che l’alpinismo
esplorativo sia ormai saturo, tu cosa ne pensi?
Per rispondere a questa domanda devo buttarla sul sentimentale… Anche
un profano di alpinismo sfogliando una qualsiasi guida percepisce che le
pareti più importanti delle Alpi sono ormai sature di itinerari.
Al di fuori dei luoghi sacri della scalata, sfruttati e santificati già
da oltre un secolo, la situazione è un po’ diversa; in generale diciamo
che mettendo insieme fantasia e creatività con un po’ di sacrificio in
termini di fatica sugli avvicinamenti si riesce ancora ad aprire vie
importanti in giro con stile pulito.
Attenzione però, la roccia non sarà inesauribile! Consiglio sempre ai
giovani di avvicinarsi alle montagne con profonda umiltà e di entrarci
in punta di piedi con un approccio del tutto minimalista, è uno stile
del tutto controcorrente di questi tempi, ma è un vero atto di amore
verso la montagna e l’alpinismo.
Questo responsabilmente consegnerà alle future generazioni dei territori
d’avventura ancora validi qui vicino, senza necessariamente dover
prendere un aereo per recarsi in una remota valle del Pakistan.
Sei l’autore di due guide alpinistiche del gruppo della Moiazza, due
capolavori che raccolgono in modo dettagliato tutte le vie presenti,
cosa ti ha spinto a realizzarle?
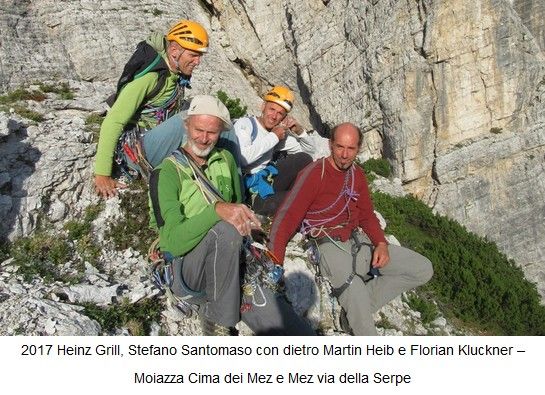 La Moiazza è la montagna che ho dietro casa, il gruppo dove ho
arrampicato più assiduamente.
La Moiazza è la montagna che ho dietro casa, il gruppo dove ho
arrampicato più assiduamente.
Fino all’inizio degli anni Ottanta le
notizie delle salite erano rare e frammentarie spesso oltremodo datate;
dopo aver percorso quasi tutti gli itinerari ho sentito quindi
l’esigenza di raccogliere tutto in una guida un po’ per una
valorizzazione storica ma soprattutto perché, secondo me, le vie erano
molto belle e meritevoli. Contemporaneamente c’era la voglia di proporre
uno sviluppo alpinistico sostenibile evitando alle pareti chiodature
sconsiderate troppo invasive. In quest’ottica ho tralasciato volutamente
i settori più orientali perché mi sembravano avere peculiarità
ambientali particolari e fragili che una massiccia frequentazione
avrebbe potuto sconvolgere. È stato un lavoro impegnativo perché mi sono
trovato aggrappato a una grande quantità di materiale da catalogare e
spesso da verificare, qualche errore è stato inevitabile ma ne è valsa
la pena.
Sapendo tutto quello che hai fatto in giro dopo l’ultima
pubblicazione, mi viene naturale chiederti, hai altri progetti in quel
senso?
Sì, ho diversi progetti in mente, di cui uno a cui tengo molto. È un
lavoro autobiografico, sto raccogliendo idee e materiale, ma non sarà un
lavoro che finirò nell’immediato.
Spero che poi qualcuno scriverà per me
l’ultima pagina.
Sono sicuro che presto vedremo qualcosa in libreria, mi piacerebbe
chiudere questa chiacchierata sentendo un po’ quello che hai fatto
recentemente, quali progetti hai per il futuro e se magari, te lo chiedo
un po’ timidamente, potresti regalarci la relazione e lo schizzo di una
tua via nuova inedita che valga la pena ripetere?
In questi ultimi anni sto vivendo una seconda giovinezza; oltre che
essere continuamente stimolato ad arrampicare in montagna dai miei
soliti inesauribili compagni di scalata, continuo a conoscere gente che
viene da tutta Europa per scalare in Dolomiti; qualcuno passa a casa per
un consiglio o delle informazioni sulle vie locali.
Alcuni sono
arrampicatori fortissimi che dopo aver ripetuto molte classiche estreme
vorrebbero ancora qualcosa di più alpinistico … sono bramosi di avventura
e pareti selvagge.
E poi, un forte stimolo per percorrere tante vie classiche che in
passato non avevo fatto è stato avviare mio figlio Manuel, ormai
diciottenne, alle scalate; la scorsa estate assieme a due ragazzi del
Belgio, ci siamo permessi la ripetizione dello Spigolo Nord dell’Agner e
un paio di nuove vie.
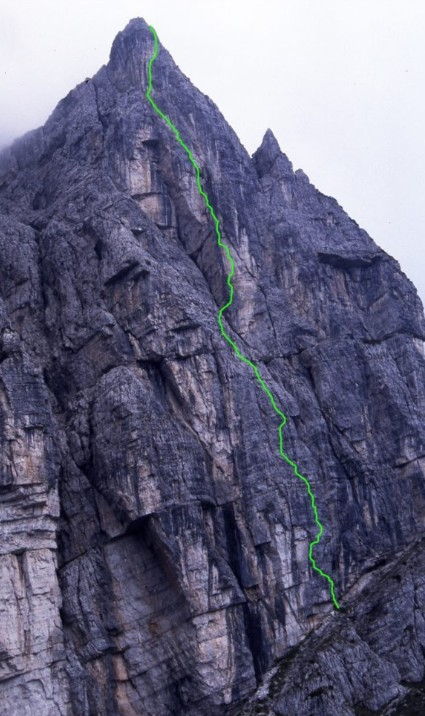
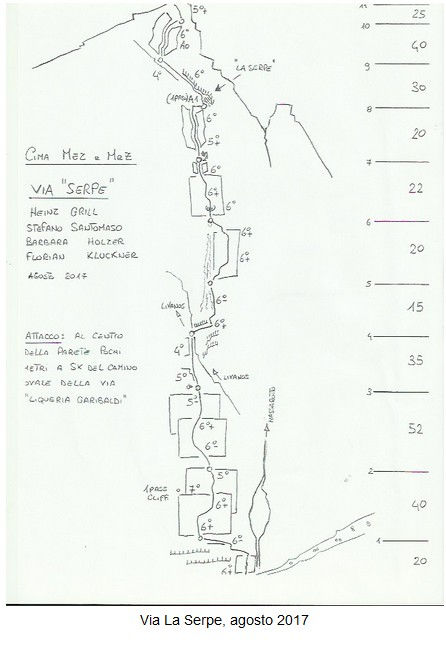
Anche con Heinz Grill vado a scalare ogni tanto,
lui è un grande, sta ripetendo a tappeto tutte le vie che ho aperto.
Siamo buoni amici, arrampicare con lui è sempre un’esperienza importante
e gratificante.
La scorsa estate abbiamo aperto assieme a degli amici
tedeschi una via sulla cima dei “Mez e Mez” in Moiazza, un itinerario
bello tosto, che darà filo da torcere ai prossimi ripetitori.
Quest’ultimo anno è stato molto prolifico, complice anche il tempo molto
favorevole; sono riuscito a compiere un quarantina di salite in montagna
di cui molte nuove ma ormai percepisco di non avere a disposizione
ancora un tempo infinito per arrampicare, per questo cerco nei miei limiti
di continuare il mio viaggio verticale.
Incastrato dai ritmi della vita ho provato ormai diverse volte a
smettere di scalare ma, peggio di un tossicodipendente, non ci sono mai
riuscito … è sempre arrivato qualcuno che mi ha detto: vuoi fare un tiro?
Pierangelo Verri
Stefano Santomaso, il funambolo agordino fra Moiazza e
Pale di San Lucano
Alpinismi (sito web) - 7 febbraio 2018