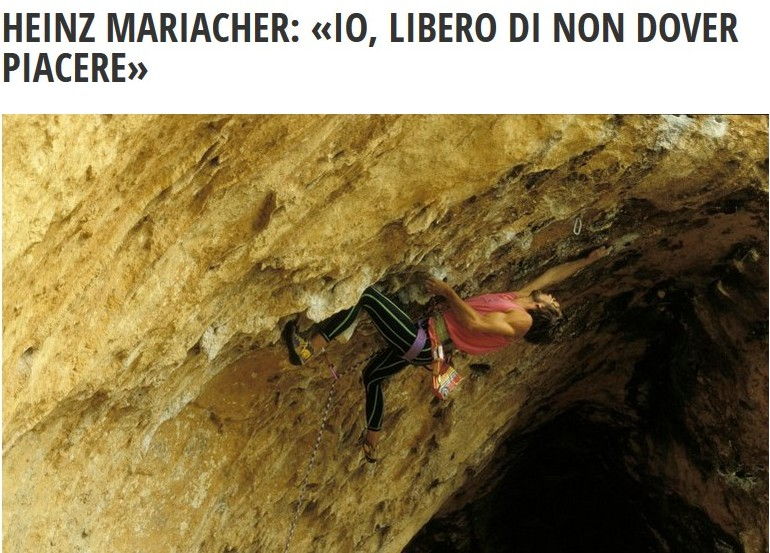
Incontro intervista con Heinz Mariacher
a cura di Emanuele Confortin
Durante la sua lunga attività ha scelto un approccio estremamente rigoroso
alla scalata, basato sull’accettazione del rischio come componente
qualitativa dell’esperienza e non quale conseguenza inevitabile.
«Il rischio ha reso interessante il nostro gioco e superare la linea
era parte di esso, altrimenti non sarebbe chiamato rischio. Ognuno deve
capire o sentire quanto lontano può andare, e a volte qualcuno va oltre».
Concetto che forse sintetizza la via scelta da Heinz Mariacher, senza
dubbio uno dei più influenti scalatori del decennio compreso tra gli
anni Settanta e Ottanta, ma la cui eredità giunge fino ai nostri giorni
ed è ancora guardata con ammirazione, almeno da chi ha cultura
sufficiente da rendersene conto.
Talvolta discusso per l’anticonformismo che ne ha caratterizzato le
scelte e l’approccio, Heinz Mariacher conserva la sana abitudine di dire
quello che pensa, di precisare quanto e quando serve.
Non è un caso, infatti, se all’inizio di questo incontro con noi di
Alpinismi, ha voluto chiarire il suo punto di vista definendosi
non-alpinista. Posizione che scaturisce dal confronto e dallo scontro
con i modelli tramandati dall’epopea dell’alpinismo eroico, della
tradizione veicolata, ad esempio, nelle spedizioni di massa contro
obbiettivi mistificati, strumentalizzati fino al punto da essere
trasformati in nemici da vincere in nome della patria, della gloria.
Heinz Mariacher si è preso la responsabilità di ribellarsi a
quell’attitudine ultra-conservativa e sistematicamente impermeabile ad
approcci differenti.
Ecco che l’esperienza in parete ha incluso
l’innalzamento delle difficoltà, a patto di riuscire a scalare in
libera, leggero e veloce, usando poche assicurazioni, spesso lontane tra
loro ma anche senza, in free solo, accettando l’incognita che ne
derivava. L’evoluzione non si è fermata alla sola scalata, fosse questa
in parete o sui monotiri cui si è orientata la fase successiva della sua
esperienza, ma ha riguardato anche i materiali.
Più precisamente dai
piedi, con il passaggio dagli scarponi da ‘alpinismo’ all’unione tra
gomma e tomaia per arrivare alle antesignane delle scarpette da
arrampicata moderne, non a caso chiamate ‘Mariacher’.
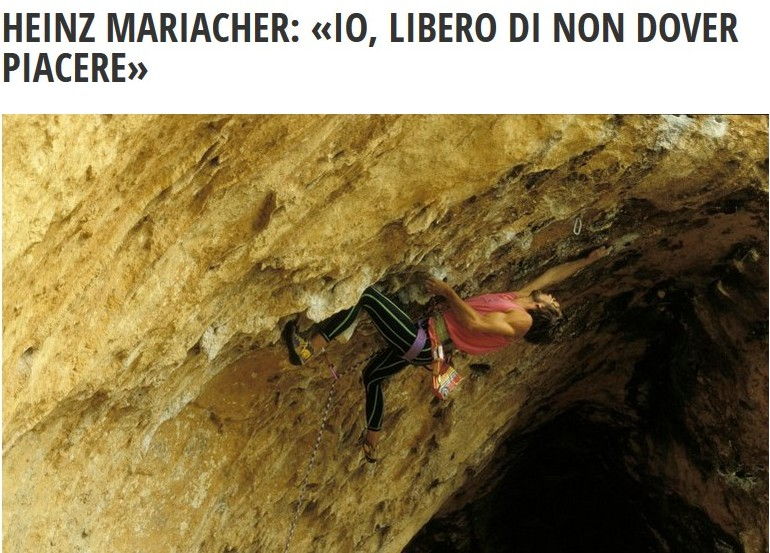
Hai avuto la fortuna di vivere in prima persona uno dei periodi più
entusiasmanti della storia dell’arrampicata. Non parlo volutamente di
alpinismo, ma di arrampicata. Riusciresti a spiegarci cosa all’epoca ti
spingeva a scalare? Mi riferisco in particolare all’attività che hai
svolto sulle grandi pareti dolomitiche. Quali principi ‘culturali’,
‘etici’, anche ‘tecnici’ o ‘sportivi’ hai posto come capisaldi della tua
attività di allora?
Mi ha da sempre attirato la roccia e non ho mai sognato di pestare la
neve per salire su cime alte. In altre parole: preferivo l’avventura
subito e diretta invece di viverla in modo lento e distanziato.
Sulla
roccia appena ti alzi per qualche metro da terra puoi trovarti in piena
avventura.
In più c’è il fascino dell’abisso, dell’aria sotto i piedi.
Da ragazzino ho arrampicato nelle gole vicino a casa, ho cercato
paretine e blocchi nei boschi, insignificanti ma sempre buoni per vivere
delle avventure. In quei tempi l’arrampicata, come la conosciamo oggi,
non esisteva ancora e c’era solo l’alpinismo tradizionale di mentalità
eroica.
L’aspetto eroico mi piaceva, amavo l’idea di sfidare il pericolo,
dimostrare coraggio e andare avanti dove altri non si fidavano, ma non
mi era mai piaciuto tutto quello che aveva a che fare con la tradizione.
La tradizione la consideravo una cosa ferma, un orientamento verso il
passato invece di inventarsi il futuro. Sono cresciuto nel Tirolo
austriaco, in un ambiente molto conservativo e questo fatto per me era
una vera ispirazione per diventare ribelle. Infatti, già da ragazzino ho
sviluppato una specie di allergia contro convenzioni e conformismo.
L’arrampicata era un’attività che non interessava a nessuno e per questo
offriva tutta la libertà di praticarla a modo mio e inventarla per me
stesso.
In molti ti definiscono uno tra gli innovatori della tua epoca e non
solo. Ti riconosci in questo ruolo?
Io mi ricordo la situazione che c’era all’epoca in cui ho cominciato
a scalare in montagna: scarponi grossi, calzoni alla zuava, tutto grigio
e marrone, zaini pesanti, tanti chiodi e staffe. Facile essere
innovatore! L’arrampicata sportiva, ad un certo punto importata
dall’America, era solo una conferma di una direzione che avevamo già
preso come logica evoluzione dell’arrampicata in Dolomiti degli anni
trenta, prima dell’epoca dell’artificiale. L’unica differenza: per noi
contava di più il minimalismo nell’uso di protezioni che il grado. Non
eravamo atleti e non consideravamo l’arrampicata come sport, ma l’idea
della libera pura era la stessa. Dopo una visita nello Yosemite (1980)
ho colto lo spirito della ricerca del massimo grado e sono stato fra i
primi in Europa ad abbracciare l’arrampicata sportiva.
Assieme a te, all’epoca, quali altri scalatori hai apprezzato per
scelte, risultati e approccio alla scalata?
 Ho vissuto due epoche molto diverse, quella da giovane avventuriero
sulle montagne di casa e nelle Dolomiti, e quella da pioniere
dell’arrampicata sportiva. Nella prima epoca ho apprezzato chi teneva ad
uno stile puristico, come i miei compagni abituali Reinhard Schiestl e
Luggi Rieser (Darshano). Eravamo in pochi che seguivano una vera etica e
bisogna ricordare e sottolineare che negli anni Settanta, vie con tanto
artificiale erano considerate più “estreme” e avevano un valore più alto
delle vie in libera con pochi chiodi.
Ho vissuto due epoche molto diverse, quella da giovane avventuriero
sulle montagne di casa e nelle Dolomiti, e quella da pioniere
dell’arrampicata sportiva. Nella prima epoca ho apprezzato chi teneva ad
uno stile puristico, come i miei compagni abituali Reinhard Schiestl e
Luggi Rieser (Darshano). Eravamo in pochi che seguivano una vera etica e
bisogna ricordare e sottolineare che negli anni Settanta, vie con tanto
artificiale erano considerate più “estreme” e avevano un valore più alto
delle vie in libera con pochi chiodi.
Nella seconda epoca c’erano tanti personaggi che si meriterebbero di
essere nominati, dal mio limitato punto di vista ho sempre ammirato
l’eleganza di Berhault e Edlinger, la forza di Güllich, lo spirito
particolare degli americani, come Kauk e Bachar, e poi gli inglesi con
la loro dedizione senza compromessi, tipo Fawcett, Moffat e altri.
Malgrado le vie che hai aperto, le ripetizioni fatte, l’innovazione che
volente o nolente hai apportato al modo di vivere l’avventura in
montagna, tu ti definisci non-alpinista. Puoi spiegarci cosa significa?
Significa che non ho voluto essere considerato “alpinista” da quando ho
realizzato che questa parola rappresentava tutto quello contro cui mi
ero ribellato da giovane. L’alpinismo era la mentalità vecchia,
l’arrampicata in artificiale, le direttissime con centinaia di chiodi e
staffe, l’eroismo glorificato, la conquista con tutti i mezzi.
L’alpinismo sugli ottomila poi, le spedizioni con regime militare,
materialismo puro in nome della patria! L’alpinismo, una volta nato come
avventura per pochi individui, oggi è diventato un movimento di massa e
per tanti un’opportunità di sentirsi grandi senza fare niente di
particolare. L’alpinismo oggi è culto e cliché, una strana espressione
di mentalità vecchia nella realtà moderna.
Ma dimmi una cosa, è l’etica che ha influenzato il tuo stile, o lo stile
ha influenzato l’etica?
Non dirmi però che sono rimaste indipendenti.
Questa domanda è un po’ difficile sic. Io direi più lo stile. Da giovane
climber ho letto pochi libri o articoli in grado di avere influenza
sulle mie scelte. Non sentivo il bisogno di orientarmi verso il passato,
e trovavo più divertente affrontare le rocce con lo spirito libero da
ingenuo principiante. Mi era però rimasta impressa la mentalità di
Preuss, Rebitsch e Messner.
Facciamo un passaggio nella tua vita di oggi, divisa tra scalata e
lavoro alla SCARPA. Come è nata l’idea delle scarpette? Posso definirti
come ‘padre’ delle moderne calzature da arrampicata?
 L’interesse per le scarpette era nato dal bisogno. Non si trovavano
scarpette sul mercato che fossero ben studiate, specialmente per
l’arrampicata in montagna.
L’interesse per le scarpette era nato dal bisogno. Non si trovavano
scarpette sul mercato che fossero ben studiate, specialmente per
l’arrampicata in montagna.
Le EB erano le migliori come prestazione, ma
al prezzo di sofferenze atroci!
La parola “padre” mi sembra un po' esagerata, ma mi pare che non ci sia
nessun altro che abbia lavorato in questo campo così a lungo e penso che
si possa dire con simile successo. Bisogna però sottolineare
l’importanza di una struttura che può realizzare le idee e fare
produzione a larga scala di alta qualità.
Da SCARPA ho trovato la situazione ideale per realizzare una linea di
scarpette straordinarie.
Ma come è iniziato tutto? Come mai un giorno ti sei messo a fare
scarpette?
È stato un puro caso: un giorno ho incontrato Alessandro Grillo a Finale
Ligure. Dopo l’arrampicata mi ha invitato a casa sua dove mi ha
introdotto al suo lavoro su una scarpa che stava sviluppando assieme con
Patrick Berhault per il marchio San Marco. Era un progetto interessante,
una vera alternativa alle EB.
Mi ha dato qualche prototipo e così ero un po' coinvolto anch’io, imparando cose importanti sulle forme e altro.
Con
questa occasione vorrei dire ufficialmente grazie ad Alessandro.
Queste scarpette di cui tu sei uno dei padri, sono oggi uno strumento
indispensabile per tutti gli arrampicatori, inclusi i professionisti dei
circuiti agonistici che si preparano ad approdare alle Olimpiadi. Cosa
pensi dell’ammissione dell’arrampicata sportiva tra le discipline
olimpiche?
Penso sia il colpo mortale per lo spirito originario della scalata.
Non credi possa essere uno spartiacque nella storia dell’arrampicata? Da
una parte il mondo delle pareti, dell’alpinismo, dall’altro lo sport
orientato alla prestazione pura?
Quel mondo delle competizioni è già stato creato, esiste già, le
Olimpiadi sono solo la conferma definitiva.
Il mondo dell’arrampicata è
completamente cambiato, sempre più competitivo, non c’è più un approccio
‘rilassato’, non c’è più il desiderio di ritirarsi in un luogo
tranquillo, di vivere una vita parallela quando si scala.
Oggi
l’arrampicata è uno sport come tanti altri, sta perdendo sempre di più
gli aspetti che la rendevano qualcosa di particolare. Questa mentalità
ha infiltrato tutto, anche l’alpinismo. Ovviamente sto parlando della
situazione in generale, e vorrei ricordare che ci vuole il conformismo
per essere non-conformista. La libertà di scelta c’è sempre.
Cosa pensi delle competizioni in arrampicata?
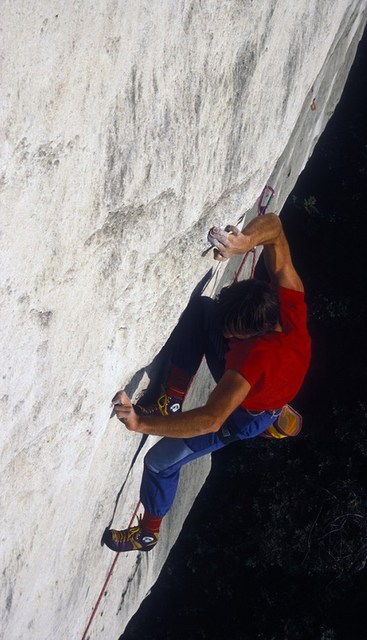 Non voglio dare l’impressione di essere contro le gare, anzi, è il
contrario.
Non voglio dare l’impressione di essere contro le gare, anzi, è il
contrario.
Sono assolutamente a favore e spesso seguo le competizioni
via livestream. Rispetto molto i giovani che si impegnano nelle gare,
come ho un grande rispetto per chi riesce a emergere in falesia, cosa
ormai difficile considerando il livello alto dei comuni climbers del
fine settimana.
Il cosiddetto “alpinismo professionale” invece non mi è mai piaciuto
tanto, perché è un modo molto dubbioso di paragonarsi agli altri.
Pensiamo all’assurdo fatto che ormai è uso normale annunciare i “record”
già prima di partire da casa! In primo piano c’è sempre lo scopo di
vendere l’impresa come qualcosa di importante e l’importanza viene
definita dai protagonisti stessi.
Il tutto funziona grazie al background
della storia dell’alpinismo e un pubblico sempre orientato verso il
passato.
Nell’alpinismo mi è sempre piaciuta la prestazione spontanea e non
pianificata.
Ritengo che la competizione debba rimanere nell’ambito
delle gare, con i giudici e le regole, non nell’alpinismo.
Dando per assodato che ogni pratica sportiva, ogni attività
professionale, o un movimento culturale sono soggetti a cambiamenti nel
tempo dettati dall’evoluzione del contesto in cui vengono svolte, o
della tecnologia disponibile per farlo, l’alpinismo di punta oggi giorno
ritieni continui a mettere la ricerca e l’innovazione al primo posto?
Cos’ha in più, o in meno, l’alpinismo di oggi rispetto al non-alpinismo
che hai praticato all’epoca?
“L’alpinismo di punta” è un’espressione strana che ha diverse
definizioni: quella dei giornalisti e sponsor, quella degli alpinisti
come comunità e quella dei singoli individui. La vera ricerca e
innovazione vengono sempre da questi ultimi, ma non è detto che siano
automaticamente riconosciute dagli altri. La domanda è soprattutto cosa
si intende con alpinismo di punta? Per la gran parte della gente
significa quello più pubblicato e sponsorizzato e l’opinione dei veri
insider ha poca importanza.
In pratica, in questi tempi tutti sembrano avere un gran bisogno di
comunicare in diretta qualsiasi gita in montagna. La montagna non è più
considerata una possibilità per staccarsi, ma al contrario un’occasione
per farsi vedere e fare notizia. In questa corsa disperata per il
riconoscimento sociale, la ricerca e l’innovazione hanno poca
importanza.
Il “non-alpinismo” è caratterizzato dalla libertà di non dover piacere a
nessuno e per questo è puro e autentico.
Il “non-alpinismo” non ha
alcuna importanza per il resto del mondo.
Da quanto avevo colto nel nostro primo breve confronto, tu vedi nella
logica degli sponsor un limite quasi imposto all’alpinista (di alto
livello) e di conseguenza la parabola ‘evolutiva’ dell’alpinismo rischia
di assecondare questa direzione. Ci spieghi cosa pensi al riguardo?
Bisogna mettere in chiaro, gli sponsor non hanno nessuna colpa. Il
problema sono gli alpinisti che si orientano su richiesta invece di
essere innovativi. L’alpinismo dovrebbe solo essere importante per noi
stessi, ha valore per chi lo pratica con pura passione e scopo
personale.
L’alpinismo “professionale” ha spesso l’aria del “costruito
per la vendita”, e perde autenticità e naturalezza.
Con questo non
voglio dire che tutti i “professionisti” producono le loro imprese solo
secondo i criteri degli sponsor, c’è sempre l’eccezione che conferma la
regola. Esistono anche i “non-professionisti” che fanno cose
straordinarie che rimangono “sotto il radar” dei media e del pubblico.
A parte tutto questo, se siamo sinceri, vendersi come eroe di montagna è
diventata una cosa quasi ridicola in tempi dove la vita non sembra più
avere valore, dove altri si fanno saltare in aria in nome di dio o di
ideologie.
Ci sono milioni che soffrono la fame e sono in fuga dalla
miseria e dal costante pericolo di essere uccisi.
Come si può ancora
ammirare qualcuno che soffre la crisi del benessere e va in Himalaya per
fare turismo estremo, perfettamente attrezzato, con corde fisse,
assistito da sherpa e accompagnato da tutto il mondo via livestream?
Oggi giorno esistono ancora non-alpinisti che a tuo parere hanno scelto
di muoversi se vogliamo in contro-tendenza? Puoi citarne qualcuno?
Sono tempi difficili, qualsiasi cosa uno inventa diventa presto
tendenza. Chi ha idee e talento particolare rimane per poco da solo,
perché non c’è più quel genere di rispetto che impediva ai mediocri di
seguire chi è avanti.
La poca chiarezza nello stile lo rende facilmente
possibile. Per rispondere alla domanda, se esiste ancora chi si muove in
Contro-tendenza, direi di sì. C’è ancora e ci sarà sempre chi riesce a
vivere senza action camera e social media. Citare dei nomi sarebbe un
controsenso e non nel loro interesse.
L’ultima domanda riguarda ancora te, e torna a qualche anno fa. Ad un
certo punto della tua esperienza – se non sbaglio – hai deciso di
smettere con le pareti, di farla finita con il non-alpinismo per
scendere di quota e dedicarti all’arrampicata sportiva.
Quali sono state
le ragioni alla base di questa scelta? Eri appagato? Avevi forse perso
gli stimoli?
Oppure ti sei accordo che il tuo ideale di non-alpinismo
sarebbe stato irrealizzabile?
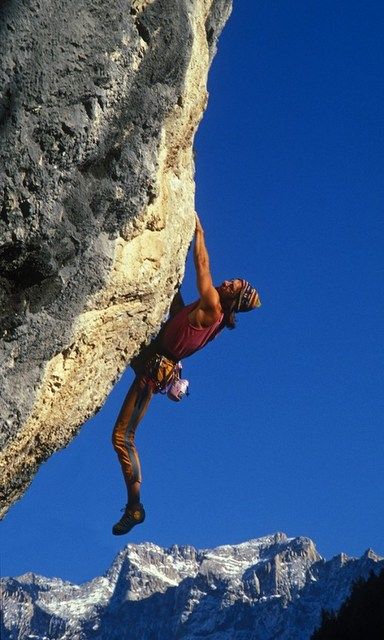 Non era una decisione, ma semplicemente un cambio di interesse. Non ho
mai deciso di non fare più vie in montagna, ho solo dato priorità a
quello che mi attirava di più al momento.
Non era una decisione, ma semplicemente un cambio di interesse. Non ho
mai deciso di non fare più vie in montagna, ho solo dato priorità a
quello che mi attirava di più al momento.
Certo, qualcosa aveva anche a che fare con gli stimoli. Sulla Marmolada
mi avevano soffiato diversi progetti, con l’aiuto dell’artificiale e con
l’uso di spit, che io volevo affrontare con uno stile più puro dando il
massimo valore all’arrampicata libera. In quella situazione era facile
trovare più stimoli nell’arrampicata sportiva dove tutti seguivano lo
stesso concetto. Mi piaceva da subito la chiarezza dello stile che in
montagna non era mai esistita e non esiste fino ad oggi. Penso che si
possa dire che il mio ideale non è realizzabile finché gli alpinisti non
si liberano dai concetti tradizionali.
Tu affermi che una delle componenti più importanti nel tuo andar per
pareti è stato il rischio.
Sostieni di aver superato in più occasioni la
linea che comunemente ferma altri arrampicatori.
C’è un episodio in
particolare in cui con il senno di poi pensi di aver davvero osato
troppo? Quando?
Ho una semplice risposta: partire senza corda per una grande parete
lascia sempre spazio alla possibilità di non tornare a casa vivo! Da
giovane ho arrampicato molto in solitaria e quasi sempre mi sono trovato
in situazioni oltre la “linea”. Le mie solitarie non hanno niente a che
fare con le solitarie in tempi attuali dove il rischio è rigorosamente
calcolato. Non mi sono preparato particolarmente e la gran parte delle
mie solitarie era su vie sconosciute. Sono sempre state azioni
spontanee e le ho sempre considerate una cosa molto personale.
Non ho
mai pensato che potessero interessare a qualcuno oltre che a me stesso.
Emanuele Confortin
Heinz Mariacher: Io, libero di non dover piacere
Alpinismo.it, 20 marzo 2017