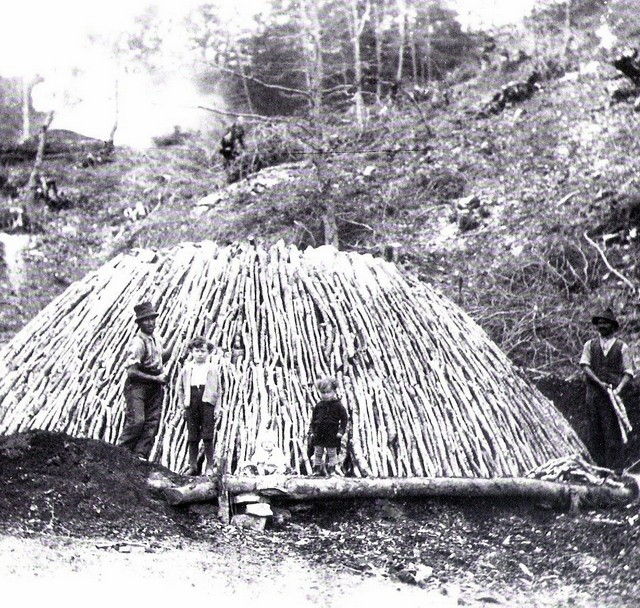Vita nel bosco
di Villy Sciarratta
Incontrai Carolina la prima volta davanti alla sua casa,
mentre intrecciava vimini per fare cestini.
Mi fermai a guardare come con quanta maestria sapeva annodare e far crescere
ad ogni istante quei suoi tesori, così umili ma così utili un tempo.
Le sue mani nodose erano agili e certamente, pensavo, quello doveva essere
stato il suo lavoro sin dalla giovane età. Mi sedetti accanto a Lei.
Ogni anno Carolina tornava dalla Francia dove era emigrata con i figli per
cercare quella vita che la montagna, avara di soddisfazioni, le aveva
negato.
 Non
tutti gli emigranti amano ricordare e raccontare quella che era stata la
loro esistenza prima della partenza verso un paese straniero. Carolina no,
le piaceva aprirmi quel mondo per me allora sconosciuto, di vita difficile
vissuta in un bosco dell'Appennino, quando la sussistenza era legata ad una
mucca, ad un orto, a poco fieno e a tanta fatica.
Nella sua piccola
abitazione di sasso i giorni trascorrevano lenti; sul soppalco di assi i
giacigli per la notte, sul nudo terreno, al di sotto, un fuoco cuoceva ogni
giorno il solito cibo e ogni giorno era necessario andare al ruscello
facendo attenzione in inverno a non lasciarsi sfiorare dall'acqua perché
altrimenti le calze diventavano arabeschi di ghiaccio.
La
vita era scandita dal susseguirsi delle stagioni.
Non
tutti gli emigranti amano ricordare e raccontare quella che era stata la
loro esistenza prima della partenza verso un paese straniero. Carolina no,
le piaceva aprirmi quel mondo per me allora sconosciuto, di vita difficile
vissuta in un bosco dell'Appennino, quando la sussistenza era legata ad una
mucca, ad un orto, a poco fieno e a tanta fatica.
Nella sua piccola
abitazione di sasso i giorni trascorrevano lenti; sul soppalco di assi i
giacigli per la notte, sul nudo terreno, al di sotto, un fuoco cuoceva ogni
giorno il solito cibo e ogni giorno era necessario andare al ruscello
facendo attenzione in inverno a non lasciarsi sfiorare dall'acqua perché
altrimenti le calze diventavano arabeschi di ghiaccio.
La
vita era scandita dal susseguirsi delle stagioni.
In primavera si preparava
il terreno per l'orto e si seminava secondo la luna. In estate ci si
svegliava quando ancora non era sorto il sole per andare alla raccolta dei
mirtilli e dei funghi e a volte era necessario fare anche tre viaggi al
giorno se la raccolta era abbondante.
In
autunno si seccavano le castagne e si andava al mulino per ottenere quella
farina che era cibo quotidiano durante l'inverno. La legna si tagliava con
quelle lunghe seghe manovrate da due uomini e si accatastava sulla lesa
per portarla a casa. (La lesa è una slitta di legno, l'equivalente
della luoda veneta NdR).
In paese si scendeva solamente per acquistare il sale, le
candele e per la festa della Madonna.
Il
suo guadagno, oltre a quello proveniente dalle raccolte nel bosco, era dato
da quei cesti da lei costruiti che andava a vendere dall'altra parte della
montagna.
Da Albareto, in Val Taro, arrivava sino a Zeri, in Lunigiana e lì
si fermava due giorni, passando la notte in qualche fienile che una famiglia
compiacente poteva offrirle.
Ma la strada del ritorno non sempre era facile. Una volta la sorprese la
nebbia, fitta come non mai, e Carolina perse l'orientamento. Con la fioca
luce che poteva dare un fiammifero che portava sempre con sé riuscì a farsi
scorgere da un uomo che la caricò su un carro e che le indicò poi la strada
giusta da percorrere.
La
vita nel bosco non era facile. I bambini dovevano percorre quasi due ore di
strada per raggiungere la scuola e allora in inverno qualche famiglia amica
li ospitava per qualche tempo in paese.
Carolina non sentiva la solitudine; non solo aveva la compagnia dei suoi
animali da accudire, ma c'erano tutti gli altri abitanti del bosco che
venivano a farle visita: il riccio aveva il suo posto preferito per
trascorrere il letargo e allo scoiattolo non mancava mai una noce da
portarsi nel nido; anche l'istrice si faceva vedere ogni tanto e al ghiro,
prima dell'inverno, bisognava procurare una scorta di castagne. Ma erano gli
uccelli notturni quelli che amava di più: lei non aveva paura del richiamo
della civetta e il gufo era una rassicurante compagnia.

“Il
bosco era tutto.” - mi diceva Carolina.
"In
primavera arrivavano i carbonai con la loro antichissima arte non priva di
mistero, e noi passavamo giorni a veder costruire la carbonaia.
Quasi tutti arrivavano dal Veneto, portandosi coperte, qualche scodella, una
pentola, una capra per il latte, qualche gallina per le uova. Arrivavano con
grossi sacchi sulle spalle che contenevano gli attrezzi da lavoro: scure e
accetta per abbattere l'albero, una roncola per rompere i rami, una lunga
sega per tagliare i tronchi, mazze e tagliole per spaccarli. Costruivano
loro stessi le baracche dove avrebbero abitato.

Tagliavano giovani tronchi di leccio che dovevano costituirne l'armatura e
poi provvedevano a rivestirla di zolle con la parte erbosa rivolta verso
l'interno, così che dall'esterno parevano capanne di fango.
Noi aspiravamo il penetrante odore che dà la polpa del legno, e da lontano
sentivamo i loro ritmici colpi.
Era l'unico rumore che ci diceva che il bosco era finalmente abitato.
A volte anche noi andavamo a cuocere il pane nei loro forni di argilla che
sapientemente costruivano accanto alla capanna e il sapore di quel pane non
l'ho mai potuto scordare.
Un
anno arrivò una famiglia con dieci figli e altri nascevano nelle baracche
senza alcun problema.
Tra di loro c'era sempre una donna che sapeva accudire le partorienti, che
sino a qualche ora prima delle doglie avevano, come ogni giorno, aiutato i
loro mariti.

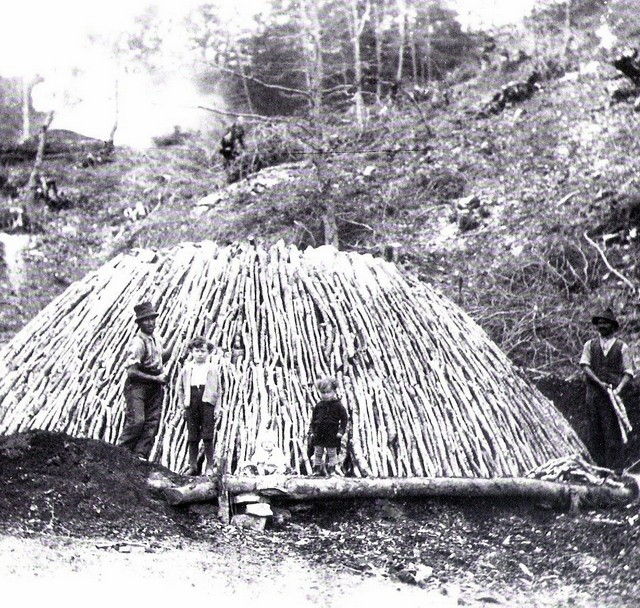
Gli
uomini individuavano una radura, la cospargevano di terra bruciata, magari
proveniente da una precedente cottura e sistemavano per primi i quattro pali
che dovevano costituire “il camino”.
All'intorno accomodavano con estrema
pazienza i tronchi di legno sino ad ottenere una costruzione a forma di
pagliaio a due piani, dell'altezza di tre o quattro metri, e procedevano poi
alla “vestizione”.
Estraevano le “cotiche” di terra dal prato e coprivano la
catasta fino al ginocchio. Per la parte restante bastava uno strato di
foglie misto a terriccio, percorso solo da alcuni sfiatatoi per regolare
l'entrata dell'aria.

Terminata la copertura davano la scalata alla carbonaia camminando sulla sua
superficie sino a raggiungere la bocca del camino per introdurre alcuni
bastoncini accesi. Anche alla base praticavano alcuni buchi, per richiamare
il fuoco a terra. Quando il fuoco si sentiva urlare, la carbonaia “aveva
preso”.
Somministrando dall'alto piccoli pezzi di legno, ogni due ore il primo
giorno, nei giorni seguenti ogni cinque o sei ore e, in seguito solo il
mattino e la sera, la carbonaia era tenuta viva.
Il
lavoro per prepararla terminava dopo accurati controlli: si doveva valutare
la resistenza della copertura, controllare che i buchi laterali fossero
abbastanza grandi per permettere l'espulsione del fumo e se la costruzione
era perfetta, e così pure l'accensione, poteva piovere e nevicare senza
alcun danno.
Ma per far circolare uniformemente la fiamma tra la fitta trama
della legna, occorreva che gli addetti all'impianto si alternassero al loro
posto di lavoro il giorno e la notte.
Solo la passione del carbonaio poteva
tenere in vita la sua carbonaia.
Quando il fuoco dalla bocca era ritornato a terra, il carbone dopo un mese
era fatto.
Allora bisognava svestire la carbonaia del suo manto di terra
diventato finissimo e, dal colore delle foglie dissecate, il carbonaio intuiva
la bontà del carbone.

Veniva estratto con un rastrello a denti lunghi e poi
sistemato in grandi sacchi di iuta per essere trasportato a valle con i
muli.

I
mulattieri erano sempre pronti; anche loro dormivano nel bosco riparandosi
solamente con il basco del mulo e andavano di monte in monte, di carbonaia
in carbonaia, tracciando con i loro animali un fitto reticolo di sentieri.
Così - mi diceva Carolina - il silenzio del bosco veniva riempito dal rumore
delle scuri che abbattevano i tronchi, dal ritmo regolare della sega, dai
passi cadenzati dei muli e dalle voci non solo di uomini ma anche di donne e
bambini”.

Così
la carbonaia nasce e si nutre, cresce e si consuma, muore e si cancella.
Ma
per anni e anni le sue tracce resteranno.
Carolina rappresentava per me la voce di questo pugno di case e dei suoi
abitanti di un tempo, quando la loro vita si svolgeva all'aperto e non
c'erano segreti per nessuno, quando la solidarietà era la loro arma, quando
l'amore per la terra non aveva confini. Nella sua lunga vita non aveva mai
perso le antiche
abitudini alle quali era legata: amava ancora raccogliere e seccare le
castagne,
pulirle con il vallo e chiamarmi poi perché le portassi al Mulino
dell'Aglio.
Poi per ricompensa mi faceva trovare sulla finestra un piatto di tagliatelle
fumanti preparate con la sua profumata farina.
A
volte i racconti di Carolina si trasformavano in poesia:


 Vecchio casone
nascosto nel bosco
Vecchio casone
nascosto nel bosco
pietra su pietra, dimora
di un tempo
antico vanto di questo bel
posto
scaldato dal sole, battuto
dal vento.
Non c'erano armadi, non
c'era ragione
un letto e una panca,
povere cose
un solo vestito ad ogni
stagione
unico lusso il gatto e le
rose.
Accanto al ruscello
tessevo i cestini
sì, perché l'acqua là
dentro non c'era
con pochi vimini sfamavo i
bambini
nasceva il giorno ed era
già sera.
Al sole affidavo tutte le
ore
il buio alla notte mi era
compagno
non c'era frastuono, ma
solo parole
potevi seguire la tela di
un ragno.
Vecchio casone, dimora di
un tempo
lì mi sentivo padrona del
mondo
udivo dei giorni il
trascorrere lento
sfidavo la notte e il gelo
profondo.
Oggi io sola sono quella
di un tempo
forse una pietra è rimasta
nel bosco
lei ancora può dire quello
che ho dentro
è l'unica cosa rimasta al
suo posto
Ho voluto percorrere i
sentieri di Carolina in una giornata d'estate e raggiungere il luogo della
sua antica dimora che mi aveva indicato.
Costeggiando un ruscello, dopo due ore di ripido sentiero, una radura mi è
comparsa all'improvviso tra gli alberi.
Il
sole la illuminava e una piccola costruzione in sasso stava attendendo da
anni un visitatore.
Quel silenzio antico sembrava serbare il ricordo di chi
l'aveva abitata: il vecchio focolare diceva che lì c'era stata vita.
Non
c'era tristezza in quell'abbandono, ma un invito a sostare su quelle pietre
sudate per assaporare le sensazioni remote che affioravano dalle fatiche di
un tempo.
Villy Sciarratta
Vita nel bosco
Albareto (Parma) novembre 2017